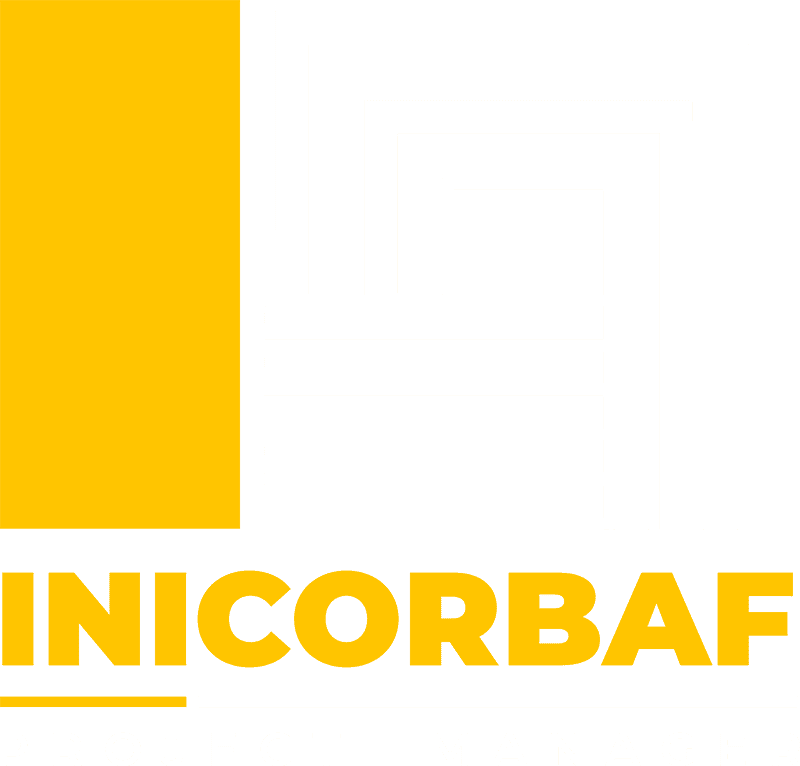Azioni di società non quotate: il rischio nascosto dell’illiquidità e la tutela del risparmiatore secondo MIFID II
Nel panorama degli investimenti, le azioni di società non quotate (spesso chiamate private equity in senso lato) rappresentano un’opportunità suggestiva quanto insidiosa. Si tratta di partecipazioni in società che non sono ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati e che, per loro natura, sono illiquide, cioè difficilmente vendibili in tempi e modi certi. Questo elemento, troppo spesso sottovalutato o comunicato in modo ambiguo, costituisce invece un fattore di rischio primario, soprattutto per il risparmiatore retail che potrebbe avere necessità di accedere rapidamente alle proprie risorse.
Illiquidità: un rischio concreto, non teorico
Il concetto di illiquidità va ben oltre l’inaccessibilità temporanea del capitale: significa, in pratica, l’impossibilità di rivendere le azioni se non trovando un acquirente interessato, in assenza di un mercato attivo. Inoltre, le quote di società non quotate sono spesso soggette a vincoli statutari o patti parasociali che rendono ulteriormente complesso l’exit. Questo comporta che, anche a fronte di necessità personali – come cure mediche, sostentamento familiare, o semplicemente un cambio di strategia finanziaria – l’investitore potrebbe restare intrappolato in un investimento non liquidabile, o liquidabile solo con forti sconti.
Nel caso di decesso, infine, gli eredi si trovano spesso con in mano un asset di difficile valutazione e monetizzazione, che può generare ulteriori complicazioni testamentarie e fiscali.
L’obbligo di trasparenza secondo MIFID II
Alla luce di tali implicazioni, la normativa europea MIFID II impone obblighi stringenti di profilazione del cliente e adeguatezza dell’investimento proposto. L’intervista MIFID non può limitarsi a una formalità o a un questionario da archiviare, ma deve riflettere la reale comprensione del prodotto da parte dell’investitore.
È qui che entra in gioco il concetto di fattibilità dell’investimento: la proposta deve essere coerente non solo con il profilo di rischio del cliente, ma anche con la sua pianificazione patrimoniale, la tolleranza alla perdita e – nel caso specifico delle azioni illiquide – con il suo orizzonte temporale e la possibilità di rinunciare alla liquidità per un tempo indeterminato.
È fondamentale che l’emittente e il distributore esplicitino in modo inequivocabile che:
- Non esiste un mercato secondario garantito;
- Il valore delle azioni è incerto e non oggettivamente determinabile in tempo reale;
- L’exit potrebbe non avvenire mai, oppure avvenire a condizioni sfavorevoli;
- Le eventuali distribuzioni di utili o dividendi non sono né garantite né prevedibili.
Case Study 1: Il caso Banca Agricola Popolare di Ragusa
Tra i casi più emblematici che evidenziano i rischi legati all'investimento in azioni illiquide, spicca quello della Banca Agricola Popolare di Ragusa (BAPR). Fondata nel 1889, questa banca cooperativa ha storicamente rappresentato un punto di riferimento per molti risparmiatori siciliani, che spesso hanno acquistato azioni dell'istituto considerandole un investimento sicuro e stabile.Wikipedia
Tuttavia, negli ultimi anni, numerosi azionisti si sono trovati in difficoltà nel liquidare le proprie partecipazioni. Le azioni BAPR, infatti, sono state ammesse alla negoziazione su mercati secondari con scarsa liquidità, come il segmento Equity Auction della piattaforma Vorvel (ex Hi-MTF), dove gli scambi sono limitati e il prezzo è spesso sostenuto da operazioni di acquisto della stessa banca tramite intermediari come Equita Sim .
Questa situazione ha portato a una serie di contenziosi legali. L'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) ha emesso diverse decisioni favorevoli agli investitori, riconoscendo la responsabilità della banca per non aver adeguatamente informato i clienti sui rischi legati all'illiquidità delle azioni. In alcuni casi, l'ACF ha condannato BAPR a risarcire i danni subiti dagli azionisti .
La vicenda ha attirato anche l'attenzione delle autorità giudiziarie. La Procura di Ragusa ha avviato un'indagine sulla vendita delle azioni BAPR, ipotizzando violazioni degli obblighi informativi nei confronti dei risparmiatori .
Questo caso sottolinea l'importanza di una corretta informazione e profilazione degli investitori, come previsto dalla normativa MIFID II. L'acquisto di azioni illiquide dovrebbe essere riservato a investitori consapevoli dei rischi e in grado di sostenere l'eventuale impossibilità di disinvestire in tempi brevi. È fondamentale che gli intermediari finanziari rispettino rigorosamente gli obblighi di trasparenza e adeguatezza, per tutelare i risparmiatori e prevenire situazioni analoghe a quella della Banca Agricola Popolare di Ragusa.
Case Study 2: Il caso BioPharma Invest
Nel 2021 un noto collocatore indipendente propose quote di una società biotech non quotata operante nel settore della ricerca oncologica. Il progetto fu presentato come "ad alto impatto" e con possibilità di future acquisizioni da parte di fondi americani. Diversi piccoli risparmiatori investirono importi dai 20.000 ai 100.000 euro, confidando nella redditività futura e nella possibilità di vendita dopo cinque anni.
Oggi, nel 2025, la società è ancora operativa ma non ha realizzato alcuna exit, e le valutazioni sono esclusivamente interne. Alcuni investitori hanno tentato di rivendere le proprie quote, ma non esiste un mercato e nessun acquirente si è mostrato interessato. L’unico canale di dismissione è una lista interna di prelazione che non ha mai prodotto risultati concreti. L’investimento si è trasformato in una trappola patrimoniale, con conseguenze gravi per chi aveva pianificato il recupero del capitale per far fronte a spese familiari.
Case Study 3: Start-up fintech e speculazione
Un altro esempio emblematico è quello di una start-up fintech italiana che nel 2022 lanciò un aumento di capitale riservato a investitori retail, promettendo importanti partnership con operatori bancari. I documenti parlavano di "exit strategy" entro tre anni tramite quotazione su Euronext Growth Milan. Tuttavia, la società non ha mai raggiunto gli obiettivi di fatturato e non ha presentato alcuna domanda di IPO.
Nel frattempo, i soci di minoranza sono rimasti bloccati: nessuna piattaforma, né alcuna clausola statutaria, prevede una via d’uscita. I pochi tentativi di cessione informale sono stati respinti dall’amministrazione che ha il diritto di veto sui trasferimenti. Il risultato? Un patrimonio immobilizzato, con perdita di valore implicita e frustrazione crescente tra gli investitori.
La responsabilità dell’emittente e del collocatore
In entrambi i casi, emerge un punto critico: la mancata evidenziazione dell’illiquidità come rischio centrale. Le informative fornite erano spesso enfatiche, puntando sulle potenzialità di crescita e tralasciando i limiti strutturali del prodotto. Alcuni clienti hanno scoperto solo in seguito che non sarebbe stato possibile uscire dall’investimento, e oggi valutano azioni legali per violazione dei doveri informativi e inadeguatezza dell’investimento.
Secondo MIFID II, l’intermediario ha l’obbligo non solo di descrivere i prodotti, ma di valutare l’adeguatezza e l’appropriatezza degli stessi in base a obiettivi di investimento, situazione finanziaria ed esperienza del cliente. In altre parole, l’illiquidità non è un’informazione accessoria, ma un elemento dirimente, che può rendere l’investimento non coerente con il profilo dell’investitore medio.
Conclusioni
Le azioni di società non quotate non sono, di per sé, strumenti da evitare: possono costituire un tassello interessante per investitori sofisticati, disposti a sopportare la lunga immobilizzazione del capitale e a gestire direttamente la relazione con l’emittente. Tuttavia, la loro illiquidità intrinseca le rende assolutamente inadatte per chi ha bisogno di flessibilità o tutela del capitale nel breve periodo.
Occorre un cambio di paradigma culturale e normativo: la vendita di questi strumenti deve essere trattata con la stessa attenzione di un’operazione ad altissimo rischio, con documentazione trasparente, intervista MIFID autentica e verifiche di adeguatezza rigorose. Solo così sarà possibile tutelare i risparmiatori, evitare liti giudiziarie e costruire una cultura finanziaria fondata sulla verità, non sull’illusione.