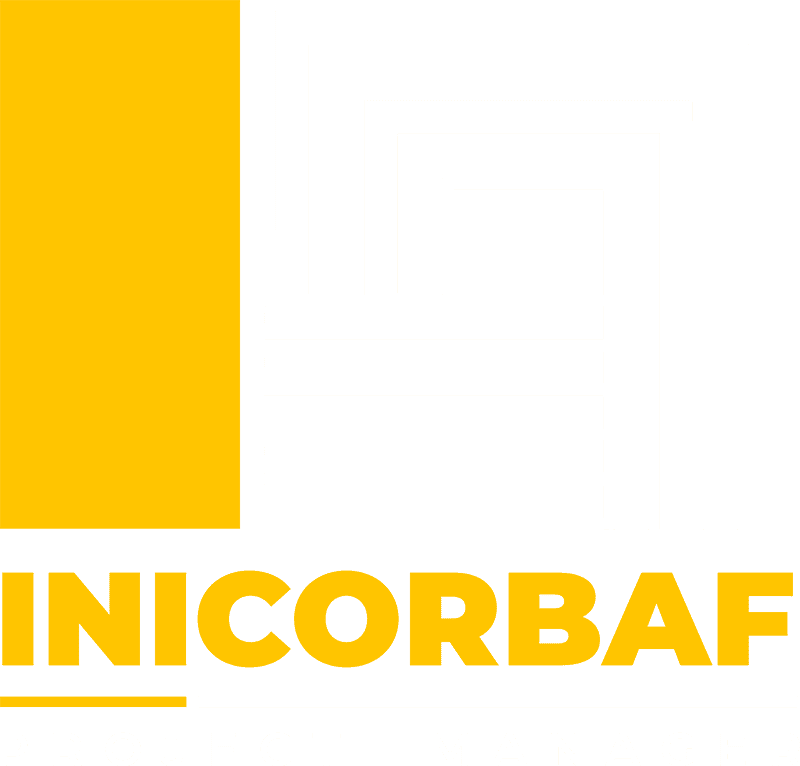Negli ultimi anni abbiamo approfondito diverse applicazioni dell’intelligenza artificiale, dall’informazione alla finanza, passando per la scrittura e i giochi di strategia, ma l’intersezione tra AI e mondo artistico rappresenta un territorio ancora poco esplorato. Una delle questioni principali che emerge riguarda la creatività e l'impatto che queste tecnologie possono avere sui processi artistici tradizionali.
Una delle criticità più importanti, ad oggi, resta quella giuridica, ovvero la definizione della proprietà intellettuale delle opere generate tramite AI. L'AI non ha una personalità giuridica, quindi la domanda rimane aperta: a chi appartiene la creazione artistica? Ai programmatori che hanno sviluppato l’algoritmo? Agli utenti che ne determinano l’output finale? La normativa europea, il cosiddetto AI Act, è stata approvata recentemente, ma non sarà attuata immediatamente, e ciò contribuisce all'incertezza giuridica ancora presente.
Tuttavia, occorre sottolineare che l’utilizzo degli algoritmi per produrre opere d'arte non rappresenta una novità assoluta; quello che è cambiato è l’accessibilità di queste tecnologie, ora disponibili non solo a professionisti del settore, ma anche a chi ha competenze limitate e potrebbe utilizzarle superficialmente.
In Italia c’è molto interesse, ma anche diffidenza verso l’AI, specialmente per quanto riguarda le possibili ripercussioni negative sul mercato del lavoro nel campo grafico e fotografico. Questa situazione richiama da vicino quanto accadde nel XIX secolo con l’avvento della fotografia: inizialmente percepita da alcuni come una minaccia, finì poi per liberare gli artisti dall’obbligo della rappresentazione realistica, favorendo così nuove correnti artistiche.
Per esplorare più a fondo questa fase di transizione abbiamo interpellato Maria Grazia Mattei, critica d'arte e presidente di MEET, il Centro internazionale di Cultura Digitale. Secondo Mattei, nonostante il crescente interesse, non esistono ancora grandi correnti artistiche basate esclusivamente sull'intelligenza artificiale, sebbene artisti come Refik Anadol abbiano utilizzato con successo tecniche come le Generative Adversarial Networks (GAN) già dal 2015.
L’utilizzo pratico dell'AI nell’arte, spiegato da Mattei, avviene tramite dataset estremamente vasti che contengono miliardi di informazioni e dati. Partendo da questi dati, l’AI è in grado di creare opere che non sono semplici collage di immagini preesistenti, bensì nuove creazioni, nate dalla rielaborazione e dal completamento di singoli elementi a livello di pixel.
Secondo Mattei, il ruolo centrale resta comunque quello dell'artista, che con la propria sensibilità e conoscenza può guidare l’AI a produrre opere davvero originali e innovative. Non basta, dunque, avere semplicemente accesso alla tecnologia per essere considerati artisti. È necessario possedere competenze specifiche e una sensibilità artistica coltivata con dedizione e passione.
Per Mattei, una delle principali criticità che emergeranno sarà proprio la necessità di distinguere chi utilizza superficialmente queste tecnologie da chi ne sfrutta appieno le potenzialità creative. È fondamentale, afferma Mattei, formare una generazione di artisti capaci di interpretare la realtà digitale non come una semplice evoluzione tecnica, ma come una vera e propria rivoluzione culturale.
Un’altra sfida riguarda l’immaterialità delle opere create tramite AI. L'arte, tradizionalmente legata ad oggetti fisici da collezionare ed esporre, si trova oggi di fronte alla necessità di gestire opere che esistono esclusivamente in formato digitale. Nonostante le iniziative come gli NFT abbiano tentato di dare una risposta alla richiesta di proprietà, il mondo dell’arte digitale resta ancora in una fase di esplorazione e sperimentazione.
In definitiva, siamo di fronte a un momento di grande potenzialità, in cui l’AI potrebbe affermarsi come un'importante risorsa parallela all'arte tradizionale, capace di attirare nuove professionalità e nuovi mecenati pronti a coglierne il valore innovativo.