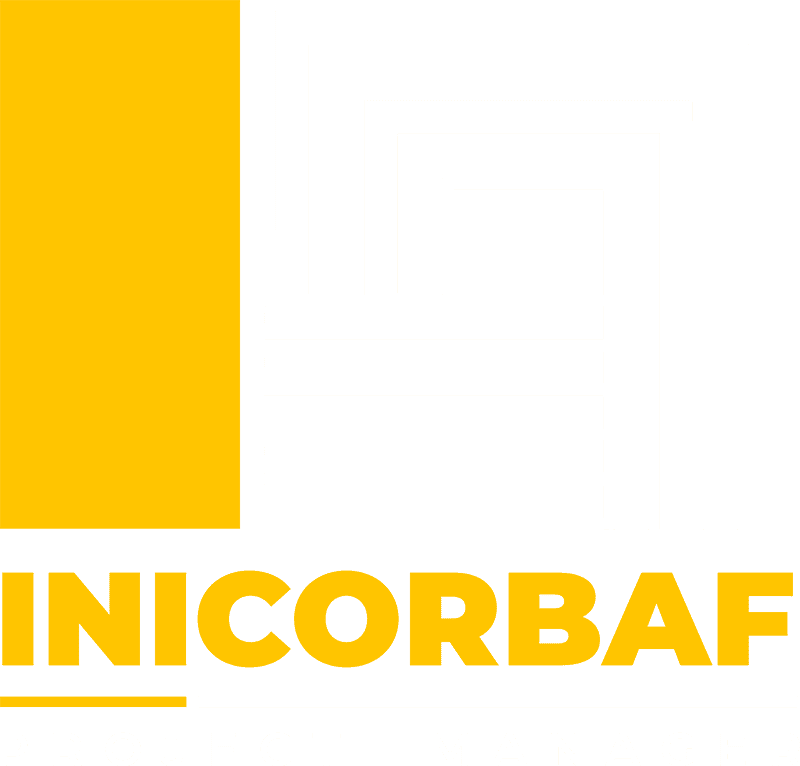Siamo a metà degli anni Sessanta. I semi gettati da Markowitz e Sharpe stanno dando frutti rigogliosi. La finanza, che fino a pochi anni prima era poco più che una raccolta di opinioni, si sta strutturando come una disciplina scientifica, capace di formulare ipotesi, costruire modelli, fare previsioni. È in questo clima, tra lavagne universitarie e nascenti dipartimenti di economia quantitativa, che prende forma una domanda fondamentale:
“Perché un titolo dovrebbe rendere più di un altro?”
A prima vista, la risposta sembra ovvia: perché è più rischioso. Ma la vera domanda è: quale tipo di rischio viene premiato? E quanto?
Non tutti i rischi sono uguali. Alcuni sono specifici: un’azienda può fallire, un CEO può fare scelte sbagliate, un prodotto può non vendere. Ma questi rischi, se investiamo in un portafoglio diversificato, si annullano. Sono rumore.
Altri invece sono sistemici: l’economia rallenta, le banche centrali cambiano rotta, i mercati crollano. Questi, per quanto diversifichi, non puoi evitarli. E sono proprio questi rischi sistematici che – secondo il CAPM – vengono premiati.
Nasce così il Capital Asset Pricing Model, sviluppato in modo indipendente da William Sharpe, John Lintner e Jan Mossin. L’idea di fondo è tanto ambiziosa quanto elegante: costruire una formula che spieghi il rendimento atteso di un titolo in funzione del suo rischio sistematico rispetto all’intero mercato.
La formula è questa:
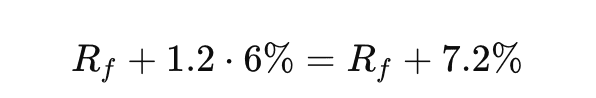
Cosa significa?
- E(Ri)E(R_i)E(Ri): rendimento atteso del titolo i
- RfR_fRf: tasso privo di rischio
- E(Rm)−RfE(R_m) - R_fE(Rm)−Rf: premio per il rischio di mercato (rendimento del mercato meno il tasso risk-free)
- βi\beta_iβi: sensibilità del titolo i al rischio di mercato
Tutto ruota attorno a questo misterioso beta. Il beta è un coefficiente che misura quanto un titolo si muove in relazione al mercato.
- Un beta pari a 1 significa che il titolo segue l’andamento del mercato: se l’indice guadagna il 10%, il titolo pure.
- Un beta superiore a 1 indica un comportamento amplificato: più guadagni, ma anche più perdite.
- Un beta sotto l’1 significa che il titolo è meno volatile del mercato.
- Un beta negativo – cosa rara – indica che il titolo si muove in senso opposto rispetto al mercato (pensiamo ad esempio a certi beni rifugio).
Il CAPM sostiene che solo il beta “conta davvero” nel determinare il rendimento atteso. Perché tutto il resto – gli incidenti aziendali, le scelte manageriali, le mode del settore – è rumore cancellabile tramite diversificazione. E solo ciò che non si può cancellare, cioè il rischio sistemico, deve essere compensato.
A questo punto, il modello diventa anche una guida alla selezione degli investimenti. Se un titolo ha un beta di 1.2, e il premio di mercato è del 6%, il suo rendimento atteso sarà:
Rf+1.2⋅6%=Rf+7.2%R_f + 1.2 \cdot 6\% = R_f + 7.2\%Rf+1.2⋅6%=Rf+7.2%
Se rende meno di questo, è sopravvalutato. Se rende di più, è un’occasione.
Semplice, lineare, perfetto. Ma come ogni modello elegante, il CAPM ha il suo tallone d’Achille.
Prima di arrivarci, però, va detto che l’impatto culturale del CAPM fu enorme. Finalmente la finanza aveva una “formula dei prezzi”, un’equazione che metteva ordine nel caos. Nacque la Security Market Line, la linea che su un grafico mostra, per ogni livello di beta, qual è il rendimento “giusto”.
Fu un successo accademico e professionale: analisti, consulenti, gestori di fondi iniziarono a calcolare i beta come si calcolano le ore di sonno o i battiti cardiaci. Era entrata una nuova religione: quella della razionalità lineare.
Ma proprio quando tutto sembrava funzionare, emersero i primi dubbi.
I mercati reali, infatti, non si comportano come quelli descritti dal CAPM. Gli investitori non sono sempre razionali. Le informazioni non sono perfettamente diffuse. I rendimenti non sono sempre distribuiti in modo normale.
Soprattutto: titoli con beta basso, in molti casi, rendevano più del previsto. E viceversa, i titoli ad alto beta non sempre offrivano un premio sufficiente.
Negli anni ’80 e ’90, studi empirici (come quelli di Fama e French) mostrarono che altre variabili oltre al beta influenzano i rendimenti attesi: le dimensioni dell’impresa, il rapporto valore/prezzo, la liquidità. Il CAPM iniziava a scricchiolare.
Eppure, nessun altro modello riuscì mai davvero a sostituirlo nella sua chiarezza teorica e potenza espressiva. Il CAPM, con tutti i suoi limiti, resta una colonna della finanza moderna, un modo per pensare al rischio come qualcosa che ha un prezzo preciso, qualcosa che non è solo da evitare, ma da valutare in termini di compensazione attesa.
Se ci pensi bene, questa è anche una visione molto “moderna” del vivere: ogni scelta, ogni passo fuori dalla zona di comfort, comporta un rischio sistemico. Ma se la direzione è quella giusta, quello stesso rischio è ciò che dà senso al cammino.
Nella prossima lezione, torneremo alla pratica: ti guiderò in una costruzione concreta di un portafoglio efficiente, usando tutti gli strumenti che abbiamo raccolto fin qui. Sarà un viaggio tecnico, ma anche creativo: costruire un portafoglio è come disegnare la propria strategia di vita, un po’ prudente, un po’ coraggiosa, ma sempre consapevole.