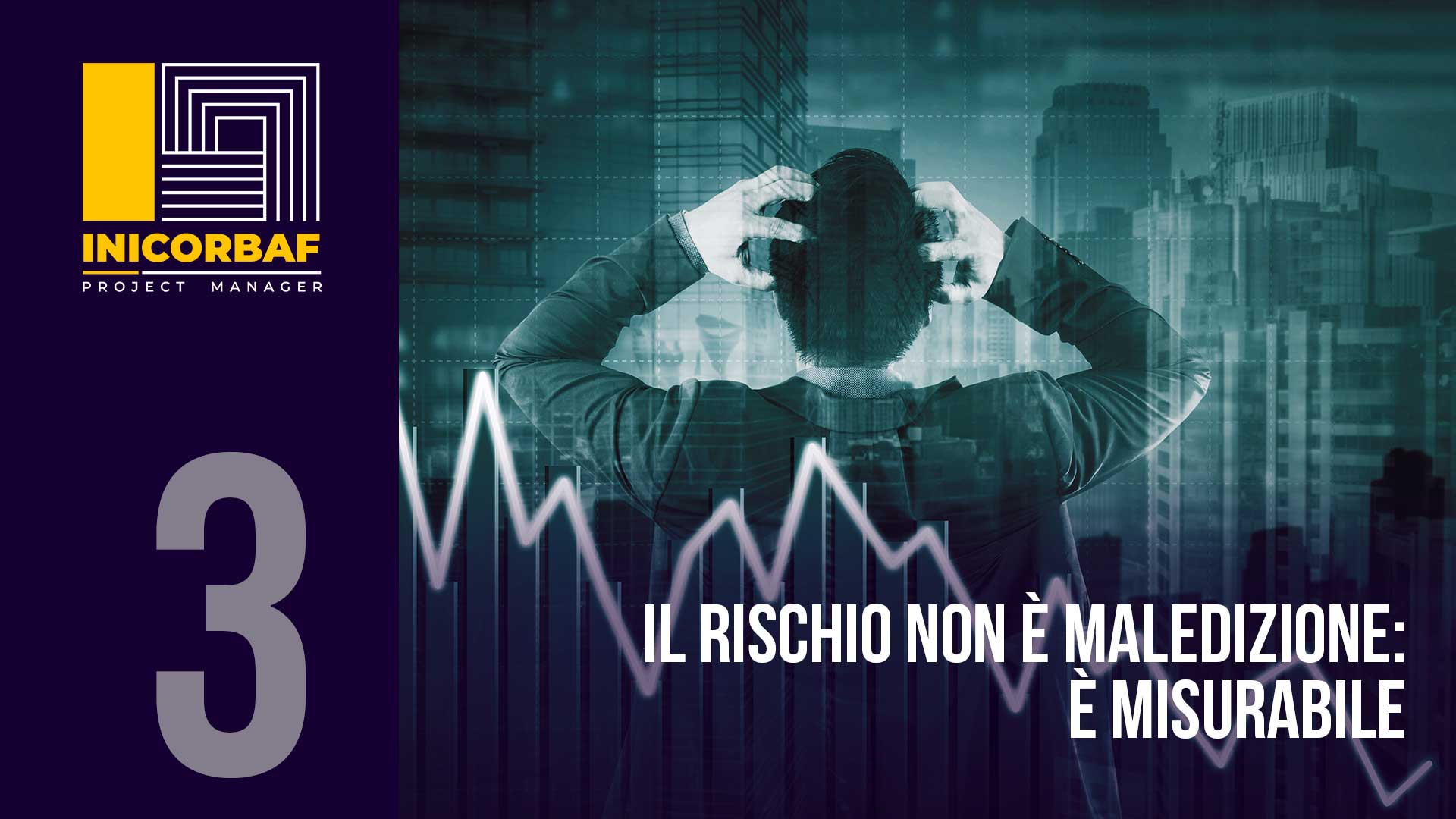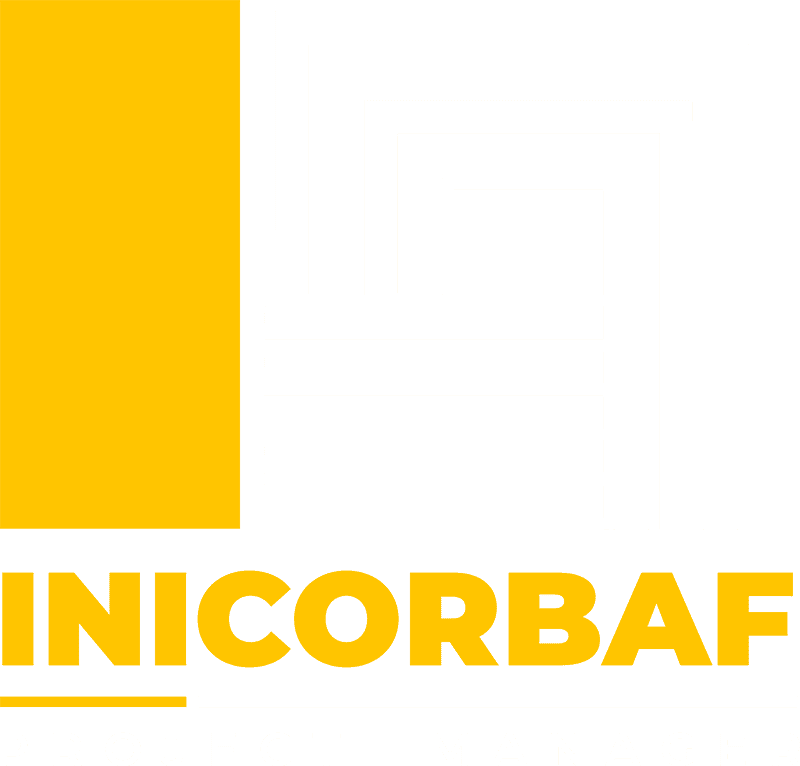Se c’è una parola che fa tremare le gambe agli investitori, è questa: rischio. È un termine che nella lingua comune evoca pericolo, perdita, guai. Eppure, nella finanza moderna, rischio non è una minaccia incombente, ma una variabile calcolabile, persino utile. Anzi, senza rischio non ci sarebbe neppure rendimento. È l’altra faccia della medaglia. Capirlo è forse il passo più importante per investire con lucidità.
Markowitz, nella sua teoria, ci ha insegnato che dobbiamo guardare a due cose contemporaneamente: quanto un investimento potrebbe rendere, e quanto quel rendimento potrebbe variare. La parola chiave è proprio questa: variare. Il rischio, in finanza, non è la probabilità di fallire, ma la possibilità che il rendimento effettivo si discosti da quello atteso. Più ampio è questo scarto potenziale, maggiore è il rischio.
Per misurarlo, la statistica ci mette a disposizione uno strumento semplice e potente: la deviazione standard. È un numero che ci dice, in media, di quanto i rendimenti si allontanano dal valore medio. Se l’andamento di un titolo è molto stabile, con oscillazioni minime, la deviazione sarà bassa. Se invece i suoi rendimenti “ballano” parecchio, su e giù come un’altalena, la deviazione sarà alta. Ecco: la volatilità è la forma visibile del rischio.
Ma c’è un secondo concetto fondamentale da introdurre: la varianza. È semplicemente il quadrato della deviazione standard. Tecnicamente è meno intuitiva, ma in finanza è quella che entra nelle formule. Quando Markowitz calcola il rischio di un portafoglio, lo fa usando la varianza dei rendimenti. Più grande è la varianza, più ampia è l’area dell’incertezza intorno al rendimento atteso.
Fermiamoci un attimo. Rendimento atteso, varianza, deviazione standard. Stiamo mettendo insieme i mattoni di un nuovo linguaggio. Non è più il linguaggio dell’intuizione (“questo titolo mi sembra buono”), ma quello della misura (“questo titolo ha una deviazione standard del 12% e un rendimento atteso del 6%”). È un linguaggio freddo? Forse. Ma è anche un linguaggio onesto, perché non promette certezze, ma distribuzioni di possibilità.
Ora però c’è una domanda da farsi: se metto insieme più titoli in un portafoglio, come cambia il rischio? Qui arriva il colpo di genio. Markowitz dimostra che il rischio complessivo del portafoglio non è semplicemente la somma dei rischi dei singoli titoli. Dipende da come si muovono tra loro. È la correlazione il fattore decisivo.
Due titoli possono essere entrambi volatili, ma se quando uno scende l’altro sale, il loro comportamento combinato è molto meno pericoloso. È come avere due amici sbadati: se sbagliano sempre insieme, è un disastro. Ma se uno sbaglia quando l’altro è attento, si compensano. In finanza, questa compensazione si chiama diversificazione. E funziona solo se gli asset non sono perfettamente correlati.
Quando due asset si muovono in modo perfettamente coordinato, con una correlazione pari a +1, la diversificazione non serve: è come investire due volte nella stessa cosa. Ma se la correlazione è pari a zero, o meglio ancora negativa, allora metterli insieme abbassa il rischio del portafoglio senza ridurre il rendimento atteso. Questo è il segreto. È qui che la teoria si fa arte.
A questo punto, possiamo guardare il rischio con occhi diversi. Non più come un’entità nemica, ma come una variabile da modellare, da distribuire in modo intelligente. Misurare il rischio non significa eliminarlo, ma scegliere come assumerlo consapevolmente. Se accetto un rischio elevato per un rendimento elevato, va bene. Ma se posso ottenere lo stesso rendimento con meno rischio, allora sto migliorando il mio investimento.
La finanza moderna è tutta qui: massimizzare il rendimento dato un certo livello di rischio, o minimizzare il rischio dato un certo rendimento. E per farlo, devo conoscere bene questi strumenti: deviazione standard, varianza, correlazione. Non serve fare calcoli a mano: oggi la tecnologia ci assiste. Ma bisogna sapere cosa significano quei numeri, perché dietro ogni numero c’è una scelta.
In questa lezione abbiamo incontrato per la prima volta il rischio come entità matematica e relazionale. Non è più il nemico invisibile che si nasconde nei mercati, ma una componente del gioco che può essere analizzata, separata, combinata.
Nella prossima lezione parleremo della frontiera efficiente. E lì vedremo come, unendo rendimento e rischio, si costruisce una mappa delle migliori combinazioni possibili. Una geografia dell’intelligenza finanziaria, disegnata con regole precise, ma aperta alle scelte individuali.