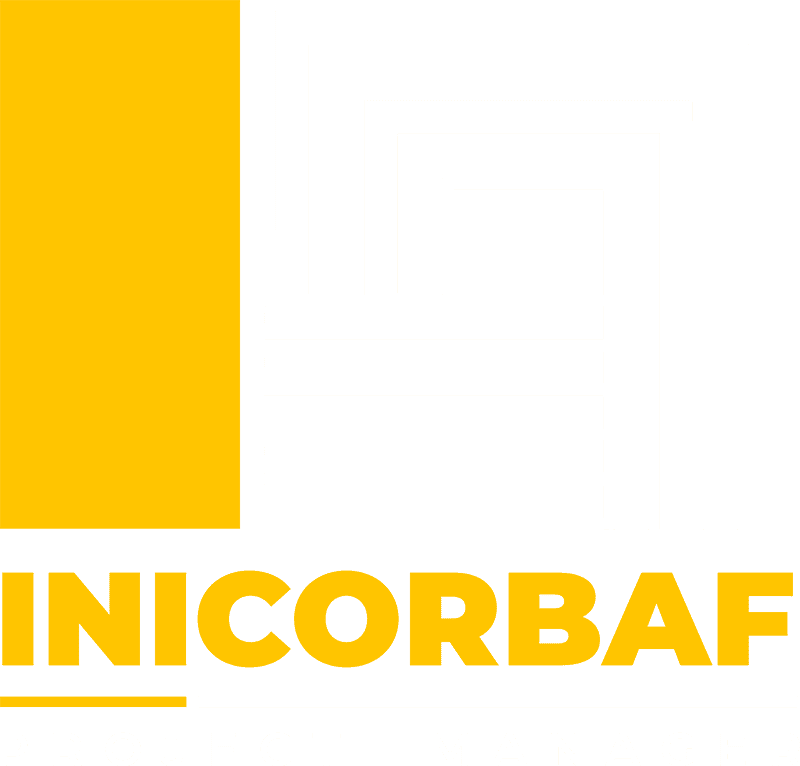Perché tutti partecipano al sistema economico, ma pochi possono comprendere e controllare quello finanziario.
Ogni giorno, volenti o nolenti, siamo parte dell’economia. Quando compriamo il pane, quando paghiamo il biglietto dell’autobus, quando riceviamo lo stipendio, quando chiediamo un prestito per ristrutturare casa. Anche un bambino, quando sceglie tra una merendina e una figurina, sta esercitando – in modo embrionale – una logica economica.
L’economia è accessibile. È esperienza quotidiana. È universale. Tutti ci vivono dentro.
La finanza, invece, è un’altra storia. È una sfera a parte, con le sue regole, i suoi codici, le sue dinamiche spesso incomprensibili ai non addetti ai lavori. È un mondo che usa parole come “bond convertibile”, “futures su derivati sintetici”, “arbitraggio” e “hedging”.
Non è fatta per essere capita: è fatta per essere gestita da chi ha gli strumenti, e, spesso, per escludere chi non li ha.
Economia come linguaggio naturale, finanza come linguaggio tecnico. L’economia parla il linguaggio delle persone. Può diventare complessa, certo – pensa a Keynes, a Hayek – ma alla base resta connessa alla vita reale.
Quando si discute di inflazione, salari, crescita, tasse, welfare, si parla di cose che, in fondo, ognuno può riconoscere sulla propria pelle. Anche chi non ha studiato economia, può dire: “Questa cosa mi riguarda”. La finanza no. La finanza ha costruito un suo codice, volutamente complesso, tecnicizzato, autoreferenziale.
Per capirla, servono competenze specifiche, tempo, accesso a strumenti professionali. Ma soprattutto, serve fiducia in se stessi, quella che molti non hanno perché sono cresciuti col mito che “la finanza non fa per me”.
E così, nasce una nuova aristocrazia: non più quella nobiliare, ma quella dei gestori, dei trader, dei consulenti, dei fondi, dei grandi investitori istituzionali.
Una élite che muove miliardi, e spesso decide il destino economico di milioni di persone che non hanno voce in capitolo.
Il caso GForex, IBS Forex, e la truffa dei diamanti. Negli ultimi anni, abbiamo assistito in Italia a una serie di truffe finanziarie che hanno travolto migliaia di risparmiatori. Persone comuni, pensionati, impiegati, liberi professionisti. Tutti attratti da promesse di guadagno, ingannevolmente presentate come “sicure”, come “garantite”.Due piattaforme che proponevano investimenti ad alto rendimento nel mercato valutario (Forex). Con modalità aggressive, promettevano margini elevati, spesso nascondendo l'elevato rischio sottostante e l’assenza di autorizzazioni.
Il caso dei diamanti da investimento, venduti anche attraverso sportelli bancari. La promessa era semplice: “Un bene rifugio, sicuro, non soggetto a svalutazioni”. Peccato che quei diamanti venissero venduti a prezzi doppi o tripli rispetto al valore reale di mercato. Le banche – che avrebbero dovuto tutelare i propri clienti – hanno spesso fatto da tramite, guadagnandoci sopra. Il piccolo risparmiatore, che pensava di investire “in qualcosa di sicuro” e si è ritrovato con pietre invendibili e zero trasparenza. Chi ci ha guadagnato? I soggetti che avevano accesso all’informazione, che conoscevano le logiche del mercato, che stavano dall’altra parte del tavolo.
La finanza non è solo un settore: è un centro di potere. Chi controlla i flussi finanziari può influenzare governi, condizionare scelte pubbliche, decidere cosa cresce e cosa muore.
Un esempio: una società tecnologica innovativa può avere difficoltà ad accedere al credito, mentre una multinazionale inquinante può ottenere facilmente fondi, se ha una buona storia finanziaria.
Non conta il valore sociale. Conta il rendimento atteso. E così, la logica del profitto a breve termine prevale sulla logica della sostenibilità, della giustizia, della coesione sociale. Questa asimmetria tra potere finanziario e potere democratico è forse la sfida più urgente del nostro tempo.
L’educazione finanziaria come strumento di cittadinanza. Di fronte a questa situazione, c’è solo una via: educare le persone alla finanza. Non per fare di tutti dei trader. Ma per difendere la propria autonomia.
Perché chi non conosce il funzionamento dei meccanismi finanziari è come un analfabeta in mezzo a una città piena di segnali stradali: rischia di sbagliare strada ogni volta, anche se è in buona fede. L’educazione finanziaria non è un optional. È uno strumento di giustizia sociale. Un cittadino che sa leggere un contratto, che sa cos’è il TAEG, che capisce cos’è un rischio asimmetrico, è un cittadino più libero. E oggi, la libertà passa anche da qui: sapere come funziona il denaro quando si muove nel tempo.
La sfida è culturale, non solo tecnica. Dobbiamo riportare la finanza nelle piazze, nelle scuole, nei giornali.
Dobbiamo pretendere che chi gestisce il risparmio altrui risponda alle stesse regole di chi lo produce con fatica.
E dobbiamo costruire una nuova cultura economica non elitaria, capace di parlare alle persone senza ridurle a clienti da “profilare”.
Perché l’economia è davvero democratica solo quando anche la finanza smette di essere una fortezza.
Quando torna a essere strumento, non fine. Servizio, non dominio. Alleato, non tiranno.