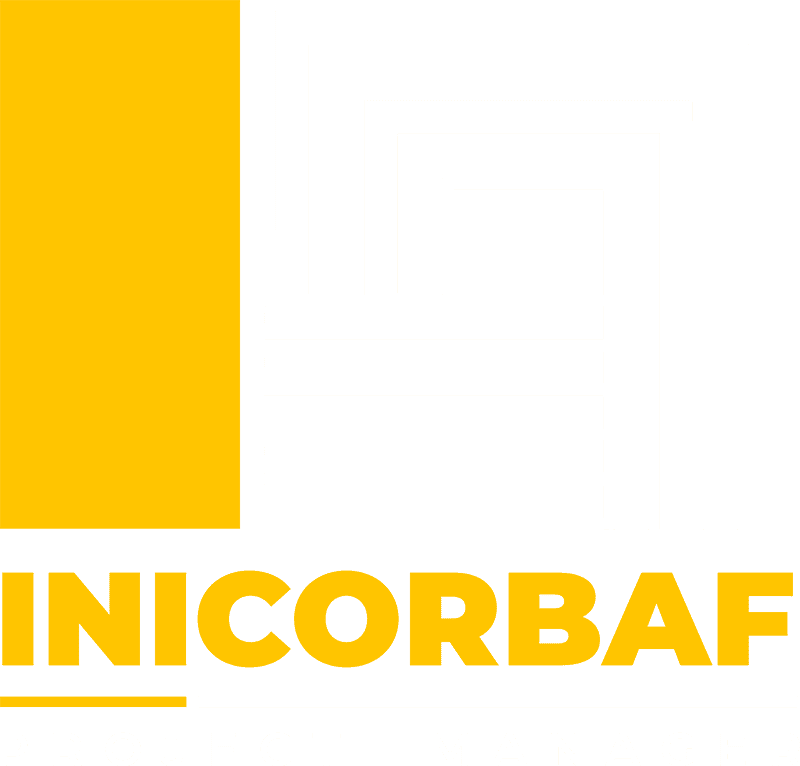Perché confondere economia e finanza è un errore culturale, non solo tecnico.
Viviamo in un’epoca in cui ogni giorno i mezzi di comunicazione ci bombardano con notizie che mescolano economia e finanza come se fossero la stessa cosa. “I mercati bruciano miliardi”, “la Borsa crolla”, “l’economia rallenta”. Espressioni come queste si rincorrono nei titoli e nei commenti, alimentando un equivoco diffuso, ma profondo: quello di considerare economia e finanza come due sorelle che camminano insieme, quando in realtà non sono nemmeno parenti. Hanno origini diverse, scopi distinti, linguaggi incompatibili. L’economia nasce dai bisogni reali, è fatta di concretezza, di esistenze vissute. La finanza si fonda invece sulle aspettative, sulle proiezioni, sulle scommesse sul futuro. Eppure, nella narrazione comune, queste due dimensioni si fondono, si confondono, creando un fraintendimento culturale che genera errori di comprensione, illusioni e, spesso, danni economici reali.
L’economia, nel suo significato originario, viene dal greco oikonomía: la gestione della casa, non del denaro. È la scienza che si occupa di come una comunità organizza la propria vita per soddisfare bisogni, per produrre, distribuire, condividere. Quando l’uomo ha iniziato a coltivare la terra, a costruire utensili, a vivere stabilmente in comunità, è nata l’esigenza di gestire la scarsità: tempo, acqua, terra, energia, lavoro. L’economia è, in questo senso, antica quanto la civiltà: nasce dalla necessità di scegliere, di valutare, di pianificare per garantire il benessere collettivo. La finanza, invece, ha una storia molto più recente e una natura completamente diversa. Nasce con il commercio internazionale, quando il valore doveva viaggiare più veloce delle monete. Le lettere di cambio, i prestiti a interesse, i contratti derivati – strumenti elaborati per evitare il trasporto fisico di denaro e ridurre i rischi – sono frutto dell’ingegno dei mercanti del Medioevo, soprattutto veneziani e fiorentini. La finanza è figlia del debito, del credito e della fiducia nel tempo futuro. Non si occupa tanto di ciò che esiste, quanto di ciò che potrebbe essere: proietta, anticipa, valuta scenari.
Per comprendere fino in fondo la differenza tra questi due mondi, possiamo dire che l’economia ha un corpo, mentre la finanza ha solo uno sguardo. L’economia è composta da persone che lavorano, producono, consumano. È fatta di mani che impastano, di cervelli che progettano, di corpi che si muovono. È la tua vita quotidiana: il pane che compri, il lavoro che cerchi, il mutuo che paghi. La finanza, invece, osserva da lontano. Analizza, anticipa, scommette. Non si sporca le mani, ma muove leve potenti. Quando una banca decide se concederti un prestito, quando i tassi di interesse si alzano, quando un fondo pensione cambia la propria strategia, è la finanza a parlare. Ma lo fa usando modelli, algoritmi, numeri. L’economia è come una partita vera, giocata su un campo polveroso. La finanza è come il tifo dagli spalti, o, più spesso, come quei commentatori in TV che si esercitano in previsioni senza mai toccare il pallone.
Un esempio tragico e chiarissimo di cosa succede quando la finanza si dimentica dell’economia è la crisi dei mutui subprime del 2007–2008. Negli Stati Uniti, per anni, milioni di famiglie sono state incoraggiate ad acquistare casa anche senza disporre di redditi stabili. Le banche hanno concesso mutui con estrema leggerezza, salvo poi impacchettare quei debiti in strumenti finanziari complessi – i famosi CDO, Collateralized Debt Obligations – che venivano venduti come investimenti sicuri. A un certo punto, il contatto con la realtà è andato perso: si vendevano debiti come se fossero ricchezza, basandosi su formule matematiche anziché su redditi reali. Quando i mutui hanno iniziato a non essere pagati, il castello è crollato. La finanza ha subito una crisi di fiducia. Ma chi ha pagato davvero sono state le famiglie, i lavoratori, le imprese: l’economia reale. Milioni di persone hanno perso casa, lavoro, risparmi. La finanza aveva creato un valore virtuale, ma quando quel valore si è dissolto, a soffrire sono stati corpi veri, esistenze concrete.
Il distacco tra finanza e realtà
Oggi questo distacco è ancora più evidente. Le Borse toccano nuovi massimi, il Nasdaq vola, le aziende tecnologiche capitalizzano più del PIL di intere nazioni. Ma fuori dagli schermi, i salari restano fermi, le disuguaglianze aumentano, l’inflazione erode i risparmi, i giovani emigrano. Com’è possibile questa contraddizione? Perché la finanza e l’economia reale non viaggiano più insieme. La finanza ha costruito un mondo parallelo, popolato di algoritmi, formule di pricing, intelligenze artificiali che fanno trading in frazioni di secondo. Ma in questo mondo spesso non si vede più la realtà: non si vedono i contratti precari, la povertà educativa, il disagio sociale. La finanza rischia di diventare una macchina autoreferenziale, che non serve più a sostenere la crescita ma solo a generare rendimenti per pochi, dimenticando le fondamenta su cui dovrebbe poggiare: il lavoro, la produzione, le comunità.
Per questo è fondamentale ricordare che l’economia è il fondamento e la finanza è solo uno strumento. L’economia nasce dalla terra, dal bisogno, dal lavoro umano. La finanza dovrebbe servire a veicolare risorse, a proteggere dai rischi, a sostenere la crescita. Quando questo equilibrio si perde, però, succede che la speculazione diventi più importante della produzione, che il valore si misuri solo in termini di capitalizzazione e non più in termini di benessere collettivo. Ritrovare il senso dell’economia reale, del lavoro e delle persone, è il primo passo verso una società più giusta, più sana e più consapevole. La finanza, per quanto potente, non semina grano, non cura malati, non educa i bambini. Questo lo fa l’economia. Questo lo fanno le persone. Questo lo fa la realtà.